Alcune riflessioni sul processo di formazione dell'identità dell'isola caraibica
Carlo Nobili
In un breve articolo apparso nel 1947 sulla diffusissima rivista americana Selezione del Reader's Digest, l'anonimo autore, facendo parlare un non meglio identificato Profeta, rifletteva sull'identità cubana, mettendo a nudo senza pietà e con palesi ed offensive esagerazioni, l'identità apparentemente contraddittoria di questo popolo. Questo stesso articolo è apparso recentemente in Internet grazie al giornalista cubano Manuel Bermín, il quale, volendo rispondere ai tanti detrattori della rivoluzione cubana, ha voluto dimostrare che l'ingegno, il genio, l'ingenuità, le cose in cui credono i Cubani ed in qualche modo anche le stesse cose negative del loro carattere, come per esempio la supposta spavalderia del Cubano, non sono un prodotto della rivoluzione castrista ma arrivano da molto lontano, sicuramente prima del 1947, anno in cui l'articolo, che segue, è stato scritto.
Una volta fu chiesto al Profeta: "Maestro, parliamo dei Cubani". Il profeta raccolse in un pugno della mano la sua tunica e cominciò a dire: I Cubani sono tra voi, ma non con voi. I Cubani bevono nella stessa coppa sia la allegria che l'amarezza. Fanno musica del loro pianto e ridono della loro musica. I Cubani prendono come cose serie le barzellette e rendono barzelletta tutte le cose serie. I Cubani credono nel Cattolicesimo, ma nello stesso tempo anche in Changó, nella sciarada e nell'oroscopo. Non credono in niente e credono in ogni cosa. Mai discutere con loro; i Cubani nascono imparati. Non hanno bisogno di leggere, sanno già tutto; non hanno bisogno di viaggiare, hanno già visto tutto. I Cubani sono un popolo eletto... ma ad eleggerli sono stati essi stessi. I Cubani si caratterizzano individualmente por la loro simpatia e la loro intelligenza e nel gruppo per il loro continuo parlare a voce alta e la loro passione. Ognuno di loro possiede la scintilla del genio, ma non ci sono geni tra loro. è facile riunirli, ma impossibile unirli. Non parlare con loro di logica, in quanto questo implicherebbe ragionamento e misura e i Cubani sono iperbolici e smisurati. Se ti invitano a mangiare, non ti portano nel miglior ristorante del villaggio, ma nel migliore ristorante del mondo. Quando discutono non dicono: 'non sono d'accordo con te', ma 'tu hai sei completamente fuori rotta'. Possiedono poi una tendenza antropofagica: 'se la comió', è una espressione di ammirazione; 'comerse un cable' è segnale di situazione critica e chiamare qualcuno 'comedor de excremento' è il più usuale e lacerante degli insulti. Amano tanto la contraddizione che chiamano 'mostro' le belle donne e 'barbari' gli eruditi. I Cubani offrono soluzioni prima di conoscere il problema, ed espressione frequente è 'non c'è nessun problema'. Quando ho visitato l'isola mi sorprendeva il fatto che qualsiasi Cubano sapeva come liquidare il comunismo e raggiungere l'America Latina, eliminare la fame dall'Africa e insegnare agli Stati Uniti come diventare potenza mondiale. Quando, come profeta, ho chiesto di predicare le mie idee, hanno cominciato a dirmi cosa io avessi dovuto fare per essere un buon predicatore. Si arrabbiano facilmente quando gli altri non comprendono le loro formule semplici ed evidenti. I Cubani vivono in qualsiasi parte del mondo e proprio non riescono a comprendere perché la gente non parla spagnolo.
Ciò che colpisce l'autore dell'articolo è, appare evidente, la contraddittorietà dell'essere cubano. Egli non riesce a trovare i margini per incastrare un qualche minimo abbozzo di descrizione dell'identità cubana. Non trova i limiti; il Cubano tende all'iperbole e ad essere smisurato, crede in tutto è in niente, mischia le cose, Santa Barbara della tradizione cattolica con Changó dio della guerra del panteon yoruba e questi con il dio guerriero chino-caraibico San Fan Con (San Falcón). Non ha tutti i torti l'autore. Descrivere l'identità cubana non è affatto semplice. Essa anche agli occhi di un antropologo appare come un grafo in continuo movimento e nel tentare di comprendere gli scenari in cui essa si muove, la vede svanire, frammentarsi, divenire labirintica da non concedere margini di autenticità e certezza, ma al contrario spingere sempre verso le mutazioni e le antropofagizzazioni.
Comer, ce lo ricorda anche l'articolo, è a Cuba verbo dai tanti significati. Il mangiare, presuppone però il digerire ed il popolo cubano sembra tra quelli che meglio ha saputo mettere in atto questa attività di digerire e metabolizzare elementi più diversi e distinti tra loro. è la storia di Cuba che fa l'identità cubana, ma possiamo anche dire che fu l'Europa a scegliere per Cuba la sua identità, mettendo nello stesso scenario a miscelare i più diversi elementi, sia cromosomici che culturali.
Oltre all'indiano (ben presto scomparso sotto la violenza dei primi anni della colonizzazione avvenuta ad opera di Diego Velásquez ed oggi rintracciabile soprattutto nei tratti somatici e culturali della comunità india di circa mille persone che vive a Caridad de los Indios, nei pressi di Yateras), vengono da subito a trovarsi nello stesso pentolone Spagnoli e Africani, questi portati sull'isola nel corso del triste capitolo della Tratta; erano e sono ancor'oggi Yoruba, erano e sono Carabalí, Congo, Arará, Mandinga, Gangá, ecc., ossia tutte nazioni africane ben distinte tra loro per storia e cultura, lingua, religione ed organizzazione sociale. Gli Yoruba furono chiamati a Cuba Lucumí e lo stesso termine indicò un po' tutti gli schiavi africani provenienti dalla Nigeria e probabilmente da altri regioni occidentali dell'Africa, soprattutto del Golfo di Guinea. Furono chiamati in questo modo in quanto si pensava che essi arrivassero tutti dal cosiddetto Regno di Ulkamí in Nigeria. In realtà, lucumí, potrebbe derivare dall'espressione di saluto in lingua yoruba oluku-mi — che significa "mio amico". Lucumí è a Cuba la Regla de Ocha o Santería, ossia quel corpo liturgico, che nato dalla fusione dei culti yoruba con la religione cattolica, si basa sul culto all'oricha (orisha, ocha, santo). Gli schiavi africani arrivando a Cuba trovarono infatti una molteplicità di santi e li adottarono, non già giustapponendoli nel loro sistema religioso, ma reinterpretandoli e utilizzandoli come un mezzo per esprimere le loro concezioni religiose. Per Congo s'intendono invece a Cuba le popolazioni di lingua bantu provenienti dall'Africa centrale. Ai Congo si devono le Reglas del Palo: in esse vi si riconoscono il Mayombe, la Brillumba e la Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Il mayombe o mayombería è direttamente connesso con il nfumbe o spirito del morto, che risiede, insieme a tutte las cargas della natura, nella nganga (un contenitore in ceramica, in ferro o in guira, anticamente fatta invece con le ossa del cranio di un morto). La Brillumba o Brillumbería è invece una derivazione creola del Mayombe, rapporto tra uomo e morto, con elementi mediati dalla Santería. La Regla Kimbisa è invece una miscela tra Mayombe, Brillumba, spiritismo ed elementi cattolici, fondata intorno alla metà del XIX secolo da Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit (più conosciuto come Andrés Kimbisa). Ai Carabalí (ossia alle etnie Efik ed Efor del Calabar) si deve invece a Cuba la società segreta magico-religiosa conosciuta come Sociedad Secreta Abakuá, i cui adepti vengono chiamati Ñañigos.
Ogni etnia africana portò a Cuba i tratti distintivi della propria cultura, siano essi Mandinga, Yoruba, Iyesá, Ibibio, Ibo, Efik, Ewé o Fon. Ma oltre agli Africani, via via nel corso degli anni arriveranno sull'isola diversi altri protagonisti.
Arrivano sull'isola i cosiddetti "Franceses", ossia i profughi haitiani che al crollo dell'impero coloniale francese furono costretti a lasciare intorno alla fine del XVIII secolo la loro isola. Erano bianchi e negri, mulatti e creoli, ex-proprietari terrieri, padroni, schiavi ed ex-schiavi. Stabilitisi soprattutto nella parte orientale di Cuba, i "Francesi" si dedicarono alla coltivazione del caffè, contribuendo così all'aumento delle esportazioni di questo prodotto proprio dai porti orientali. Seppero coltivare la terra così intelligentemente, che molti in breve tempo crearono delle buone fortune e non era raro vedere nelle città orientali e anche sin dentro i cafetales i tratti del gusto raffinato dei loro costumi: il passapied e la contredanse, i giardini versallescos, i pianoforti a coda e le eleganti carrozze.
Arrivano, come "contratados", Filippini e Yucatecos, ossia Messicani dello Yucatán. Arriveranno, così come i Cinesi, quando per gli Spagnoli si fece più urgente la necessità di contrattare lavoratori stranieri che potessero sostituire gli schiavi nei lavori dei campi. Gli Inglesi, abolita la Tratta nel 1808 e la schiavitù nel 1833, avevano infatti iniziato ad intercettare le navi negriere spagnole e a rendere di conseguenza sempre più difficile la Tratta dall'Africa.
Arrivano a Cuba nel XIX secolo i Canarios, ossia gli abitanti delle isole Canarie, considerati, perché poveri e al pari di Andalusi e Gallegos, non certo Spagnoli ma appunto Canarios, con un non so che di dispregiativo.
Durante la danza de millones, gli anni cioè del boom dell'industria zuccheriera cubana (1902-1909) arrivano sull'isola cubana emigranti, oltreché da Haiti (39.606) e nuovamente dalla Cina (1.300), dalla Giamaica (50.368), da alcune isole delle Antille britanniche, soprattutto le Leeward (24.976), da Puerto Rico (13.000), da Panama e dal Centroamerica (8.000) e un buon numero (436.005) dalla Spagna.
Tra il 1921 e il 1925 Cuba importò ancora 63.973 Haitiani e 31.212 Giamaicani. Questi ultimi formano oggi, insieme a coloro che vennero sempre intorno a quel periodo da Barbados, da Saint Lucia, da Grenada, dalle Isole Vergini Britanniche, da Saint Kitts e Nevis, da Antigua e Barbuda, da Saint Thomas, dall'arcipelago Turks e Caicos e da Trinidad e Tobago, una nutrita comunità di lingua inglese, soprattutto nella città di Baraguá, nella provincia di Ciego de Ávila. Questi immigranti, che portarono sull'isola cubana la cultura dei colonizzatori inglesi, seppero ben mescolarsi con il resto della popolazione, così che a Baraguá oggi tutte le radici, si dice, si uniscono in un solo tronco comune.
Oltre alla piccola comunità costituita dai Musulmani di Cuba, che non poco hanno influenzato l'architettura cubana con lo stile mudejar (molte sono le opere che artisti musulmani, al servizio degli Spagnoli, hanno eretto a La Habana; inoltre proprio nella capitale, nel cuore del centro storico della città, esiste il Museo de los Arabes), non bisogna dimenticare quella degli Ebrei.

Perseguitati dal Nazismo, migliaia di ebrei giunsero infatti a Cuba dalla Turchia, dalla Polonia, dalla Russia, dalla Lettonia ed da altri paesi dell'Europa con la speranza di passare negli Stati Uniti. La comunità ebraica cubana è oggi alquanto consistente: secondo una stima del 1989, essa, che venne a formarsi già all'indomani della guerra Ispano-Americana (quando alcuni dei 3.500 soldati americano-ebrei decisero di rimanere a Cuba, dove crearono il loro primo cimitero e il loro primo tempio), era composta da 892 persone (ossia 305 famiglie), di cui 635 nate da madre ebrea (70%) o da padre ebreo (30%). Sono cinque le sinagoghe presenti all'Avana, una a Santiago de Cuba.
L'identità cubana in effetti somiglia molto ad un rizoma, una radice cioè che vive incontrandosi e fondendosi con altre radici con cui divide il terreno. Quella che si è formata nel corso di cinque secoli è una identità che si è presentata da subito come caratterizzata da una capacità evidente di metabolizzare elementi e modelli culturali altri, per farli confluire in una nuova configurazione.
Il massimo pensatore cubano, il grande sociologo Fernando Ortiz, in antitesi con quello più classico di acculturazione, propugnato dalla scuola sociale britannica, coniò intorno agli anni Quaranta, per indicare la specificità del processo di formazione dell'identità cubana, un nuovo termine: parlò di transculturazione. Il concetto di transculturazione, dice lo studioso cubano, tiene conto che in questo processo hanno contribuito e quindi lasciato traccia tutti gli elementi culturali espressi dall'isola sin dal primo dei diversi momenti storici della sua colonizzazione. La transculturazione non è però espressione ferma, concetto stabilito o categoria di riferimento, ma sempre sfuggente linea d'ombra. E la linea d'ombra (volendosi concedere una licenza letteraria) è un filo sottile dove si confonde la propria con l'altrui identità; uno spazio destinato all'incontro, al confronto e al dialogo; è una zona franca che non appartiene all'io in modo assoluto ed esclusivo ma dove la propria immagine è un riflesso in uno specchio. Quella che chiamiamo cubanía è quindi un raccoglitore di svariati contenuti e di esistenze reali in costante ebollizione, mutabile comprensione e incessante scambio.
L'antropologia moderna ha insegnato che non esistono purezze etnografiche, le culture si sono sempre incontrate e fuse tra loro, malgrado le possibili e tante reciproche censure e gli infiniti frangiflutti eretti a difesa del proprio modello originale. La tendenza alla creolizzazione del mondo è un dato di fatto incontrovertibile e connaturato alla storia dell'umanità che il processo capitalistico occidentale ha solo accentuato e reso più evidente. Cuba e tutte le Antille rappresentano un esempio-tipo, uno schema assai efficace, perché qui venne a verificarsi un fenomeno forse irripetibile: una "creolizzazione perfetta", o come amano dire i Caraibici, una "combinación perfecta" o addirittura (facendo ancora leva sul gusto volutamente contraddittorio dell'animo caraibico) una "combinación pura" (evidente ossimoro) di risposte culturali, suoni, odori, gusti, lingue, storie che non rispondono mai ad un senso univoco e originale, ma sono sempre frutto di un processo multiculturale alquanto complicato e assai poco lineare.
Lo scrittore colombiano Fabio Rodríguez Amaya ha detto che per afferrare l'identità caraibica, unitaria e molteplice, meta e provenienza, è necessario concentrarsi sulle idee di frontiera, di isola, di arcipelago, di diversità, di soglia verso l'ignoto o il nuovo, poiché il suo senso non è dato da una sola lingua, da una sola etnia, da una sola terra, ma dall'economia e da quell'insieme di rapporti generati mescolando quattro mondi verso l'ignoto e verso il nuovo. La cubanía, ossia l'identità dell'isola caraibica, non fa riferimento ad una cultura in particolare ma ad una salsa di culture e la salsa cubana, espressione musicale nella quale riconoscersi tra le infinite sfaccettature del proprio io, altro non è che l'ajiaco di cui parla pure Ortiz, ossia quel minestrone di tante cose (vari tipi di carne ed ogni sorta di vegetale) messo a cuocere a fuoco lento nel pentolone di terracotta dei Caraibi, il cui risultato è il prodotto di tutti quei diversi elementi: una transculturazione, diceva appunto Ortiz.
Così come è impossibile definire e formalizzare in una precisa ricetta questo tipico minestrone cubano, allo stesso modo non è possibile descrivere la cubanía o sancirne i confini. Se ne conoscono gli ingredienti ma non quello che sarà il prodotto del loro incontro. La cubanía è quindi soltanto una griglia, una ipotesi, un progetto. Di essa invece che darne una descrizione-condanna così come fa lo sprovveduto ed anonimo autore dell'articolo che Manuel Bermín ci ha fatto conoscere, è però possibile seguirne le tracce e storicizzarne i protagonisti-ingredienti, tanti, diversi tra loro, seppur con una comune prospettiva relazionale.
 Parlare per esempio così come si fa nell'articolo di carattere spavaldo del Cubano e non tentare di storicizzare questo elemento culturale denota superficialità e scarsa conoscenza della cubanía, in quanto la sociologia cubana già negli anni Venti, ancora grazie a Fernando Ortiz, aveva rilevato che il carattere insolente, sfrontato ed arrogante che talvolta si riconosce al Cubano viene a lui dalle gesta del cosiddetto "negro curro" o "negro del Manglar" (un barrio all'estrema periferia dell'Avana). Era questi il negro libero del periodo coloniale, che tra il 1820 e il 1830 esercitò, attraverso la sua guaperia, una sorta di semipadronanza su alcune vie dell'Avana Vecchia.
Parlare per esempio così come si fa nell'articolo di carattere spavaldo del Cubano e non tentare di storicizzare questo elemento culturale denota superficialità e scarsa conoscenza della cubanía, in quanto la sociologia cubana già negli anni Venti, ancora grazie a Fernando Ortiz, aveva rilevato che il carattere insolente, sfrontato ed arrogante che talvolta si riconosce al Cubano viene a lui dalle gesta del cosiddetto "negro curro" o "negro del Manglar" (un barrio all'estrema periferia dell'Avana). Era questi il negro libero del periodo coloniale, che tra il 1820 e il 1830 esercitò, attraverso la sua guaperia, una sorta di semipadronanza su alcune vie dell'Avana Vecchia.
 L'ostentazione, la spavalderia, il tratto esagerato nell'agire e nel parlare, il gusto eccentrico nel vestire (il sombrero, calzoni a campana, la camicia bianca immacolata, fazzoletti e bottoni ovunque, oro e seta) e l'aria scanzonata e un po' da bullo, erano elementi che il "negro curro" aveva però mediato dal gitano spagnolo. Questa figura null'altro era quindi che il prodotto transculturativo dell'incontro tra un elemento squisitamente europeo (ma fortemente contaminato da influenze moriscos) ed un altro squisitamente africano.
L'ostentazione, la spavalderia, il tratto esagerato nell'agire e nel parlare, il gusto eccentrico nel vestire (il sombrero, calzoni a campana, la camicia bianca immacolata, fazzoletti e bottoni ovunque, oro e seta) e l'aria scanzonata e un po' da bullo, erano elementi che il "negro curro" aveva però mediato dal gitano spagnolo. Questa figura null'altro era quindi che il prodotto transculturativo dell'incontro tra un elemento squisitamente europeo (ma fortemente contaminato da influenze moriscos) ed un altro squisitamente africano.
"Il Cubano sa tutto e ha già visto tutto, non ha bisogno né di leggere né di viaggiare", sostiene l'autore, dimenticando che, proprio perché prodotto di un processo transculturativo — e di una società fortemente mescolata, che gli ha insegnato, attraverso atti antropofagici, a deframmentare le intraducibilità — è capace, forse ancor più di altri, a gestire codici di valori e di attribuzioni diversi e a confrontarsi con il mondo e con i suoi vari umanesimi in maniera creativa e ricca in risposte. Non è forse questa la spavalderia del Cubano? Ed essa, se vista in questo modo, non è forse un pregio e indice di "civilizzazione"? La superficialità dell'articolo è però purtroppo la stessa superficialità che contraddistingue ancora il nostro rapporto di conoscenza con l'isola caraibica.
Troppo spesso ci accontentiamo della crosta perdendo così il senso e la misura della profondità. C'è allora, a mio parere, un bisogno urgente di far conoscere Cuba, di far conoscere la sua ricchezza culturale e storica, di far conoscere soprattutto questo mondo a coloro i quali hanno eletto da qualche tempo l'isola cubana come la meta turistica preferita dei loro viaggi tropicali, ignari della vera ricchezza che sta dietro o al di là della rappresentazione che gli stessi Cubani danno di sé per essere "compiacenti" con lo straniero.
C'è, di fatto, un urgente bisogno di modificare l'immagine stereotipata e alquanto distorta che qui dall'Europa si ha di quest'isola caraibica. C'è la necessità di far comprendere che, al di là delle apparenze, ben più ricco è il processo storico che ha contraddistinto e caratterizza ancora questa terra che Colombo giudicò nel suo Diario come "la più bella che occhi abbiano mai visto", non dimenticando mai che la sua straordinaria, multiforme e variegata umanità da secoli ha imparato a recitare la sua parte in un teatro comune affollato di tanti altri attori protagonisti.
Così come non si deve dimenticare che quel teatro — a partire dal momento in cui il ricco proprietario terriero Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo suona la campana della sua fattoria, La Demajagua, liberando tutti i suoi schiavi (10 ottobre 1868) — si è via via trasformato da arena di battaglia a spazio comune e luogo di intermediazione.
In questo spazio i propri connotati si sono persi in quelli degli altri, in essi si sono confusi e da questi sono stati modificati, grazie all'azione creola esercitata da chi, arrivando sull'isola cubana, decise — di sua volontà o perché costretto —, che l'unica soluzione per scongiurare la "fine del mondo" fosse quella di interagire e mischiarsi, ossia rendersi ibridi e quindi oggi, per noi occidentali, difficilmente collocabili entro gli stessi margini che usiamo per classificare e definire la nostra moderna società complessa, che solo ora comincia a riflettere su quali possano essere le condizioni più favorevoli per la pacifica coesistenza al proprio interno di comunità differenti.
Tratto da NOBILI Carlo:
"La Cubanidad, prodotto di quattro mondi messi a miscelare verso l'ignoto e il nuovo.
Alcune riflessioni sul processo di formazione dell'identità dell'isola caraibica"
in El Moncada, Torino, Anno VIII, n. 1, 2000, pp. 28-30
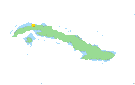


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()