|

|
Cuba |

|
|
Una identità in movimento
|
|
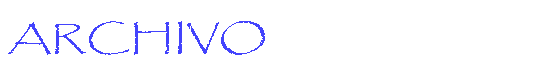
|
"Gli dei più forti sono quelli africani": il mondo religioso di Esteban Montejo, ex-schiavo e cimarrón cubano
Carlo Nobili
L'argomento del mio intervento — Esteban Montejo e la religione africana — è parte di un più ampio lavoro da me svolto intorno a quel magnifico romanzo testimoniale cubano rappresentato dalla sua biografia, pubblicata nel 1966 a La Habana a cura di Miguel Barnet. Obiettivo di quell'ampio lavoro che mi ha visto impegnato per lungo tempo e iniziato, è bene dirlo, subito dopo l'acquisto del libro in una caldissima giornata cubana nel settembre del 1996 da un simpatico, improvvisato ma eruditissimo "libraio" sulla strada tra Regla e Guanabacoa (Terra eletta dagli dei africani), obiettivo di quel lavoro, dicevo, era quello di analizzare in chiave antropologica gli elementi costitutivi del racconto allo scopo di mettere in luce i diversi apporti etnici che hanno concorso al processo di transculturazione del popolo cubano.
Questa operazione di analisi si è tentata pur sapendo che la biografia, raccolta attraverso una serie d'interviste, non è, per ammissione dello stesso curatore — che funge da "voce autorizzata", da "voce della scrittura" —, un lavoro storico: la storia appare — ce lo ricorda sin dalle prime pagine lo stesso Barnet — perché è la vita di un uomo, Esteban per l'appunto, a passare attraverso essa. Di questa storia e di questa vita si è cercato di dare conto, ricontestualizzandone le tracce e marcandone gli aspetti più visibili, in modo che si potessero ricostruire o ricercare definizioni e ambiti più generali in cui ascrivere i singoli elementi estrapolati dal racconto, ossia individuare il significato, il luogo e il tempo che stanno dentro e dietro le parole del cimarrón.
Nel racconto infatti non vi è la sola fierezza schiva, personale e per certi versi individualistica, di Esteban Montejo, vi è pure la fierezza e l'orgoglio di un popolo, quello africano, che ricostruisce un mondo inventandosene un altro, del tutto simile a quello d'origine e altrettanto a quello che gli sta intorno, adottando così una soluzione che funziona, ancor oggi, come modello per quel concetto di cubanidad o cubanía che ben rappresenta l'unicum formato dalle diverse origini e le molteplici varianti di una cultura.
Nel voler indagare antropologicamente un "fatto di letteratura" come il romanzo di Barnet, nel voler comprendere storicamente ciò che il cimarrón racconta, si fa conoscenza con un'umanità variegata, costretta a recitare da secoli in un teatro che si è trasformato, piano piano, da arena di battaglia a spazio comune e luogo di intermediazione, dove i propri connotati si perdono facilmente in quelli degli altri, in essi si confondono e da questi sono modificati incessantemente, così come questi stessi cambiano per l'azione creola esercitata su di loro da tutti quegli sguardi che, arrivando sull'isola cubana, decisero — di loro volontà o perché costretti —, che l'unica soluzione per scongiurare la "fine del mondo" fosse quella di interagire e mischiarsi, ossia rendersi ibridi. E la letteratura caraibica, lo sappiamo, è una letteratura ibrida per definizione; lo è perché è la stessa Musa dei Caraibi ad essere ibrida, composita ed elusiva, o meglio, Musa elusiva, ma vigorosa, di un'arte composita, proteiforme e poliglotta e Musa della nostalgia di un altrove perduto, o forse ancora da scoprire. Allo stesso modo che nella letteratura del capoverdiano Henrique Texeira de Souza — dove la memoria è personale ma assume ruolo di portavoce di memoria collettiva —, anche nelle modalità di espressione letteraria di Barnet la narrazione individuale di Esteban risulta essere una maniera di trasmettere memoria collettiva. Una storia creola: dove l'identità personale è motivo per connotare l'identità collettiva, improvvisa, mista, relazionale e inventiva di una nazione.
Questa identità sempre in movimento traspare dalle pagine del romanzo come se questo fosse un resoconto etnografico e nel tentare di comprendere gli scenari in cui essa si muove la si vede svanire, frammentarsi, divenire labirintica da non concedere margini di autenticità e certezza, ma al contrario spingere sempre verso le mutazioni. In altre parole, si è davanti ad una identità non più a radice unica, che esclude ogni altra, ma — volendo seguire il pensiero di Gilles Deleuze e Felix Guattari — ad una identità rizoma, una ragnatela senza centro capace di liberare la creatività individuale e di metabolizzare, in modo infinito, anarchico ed inatteso, elementi e modelli culturali altri, per farli confluire in una nuova configurazione. Il rizoma, che è sempre tra le cose, nel mezzo di esse, è un intermezzo; a differenza della radice che è filiazione e preferisce il verbo "essere", esso è alleanza e privilegia la congiunzione "e... e... e" all'infinito.
Questa identità rizomica e transculturativa non è espressione ferma, concetto stabile, categoria di riferimento, ma sempre sfuggente linea d'ombra. E la linea d'ombra (volendosi concedere una licenza letteraria giustificata dalla stessa analisi dell'oggetto in questione — un romanzo per l'appunto) può essere descritta in vari modi: filo sottile dove si confonde la propria con l'altrui identità; spazio destinato all'incontro, al confronto e al dialogo ma anche luogo di stupore e di conflitto; zona franca che non appartiene all'io in modo assoluto ed esclusivo ma dove la propria immagine è un riflesso in uno specchio; il bilico, il mantenersi in equilibrio precario; l'indefinito caleidoscopico dei propri tanti passati che torna a farsi presente reale.
Quella cubana, così come le altre identità caraibiche, altro non è che un raccoglitore di svariati contenuti e di esistenze reali in costante ebollizione, mutabile comprensione e incessante scambio.
La moderna antropologia insegna che non esistono purezze etnografiche; nessuna cultura sa essere sempre omogenea e particolarmente coerente; le culture si sono sempre incontrate e fuse tra loro, malgrado le possibili e tante reciproche censure e gli infiniti frangiflutti eretti a difesa del proprio modello originale. La tendenza alla creolizzazione del mondo è un dato di fatto incontrovertibile e connaturato alla storia dell'umanità che il processo capitalistico occidentale ha solo accentuato e reso più evidente. Cuba e tutte le Antille rappresentano un esempio-tipo, uno schema assai efficace. Qui, ma anche altrove soprattutto nelle Americhe, venne a verificarsi un fenomeno forse irripetibile: una "creolizzazione perfetta", o come amano dire i Caraibici, una "combinación perfecta" di risposte culturali, suoni, odori, gusti, lingue, storie che non rispondono mai ad un senso univoco e originale, ma sono sempre frutto di un processo multiculturale alquanto complicato e assai poco lineare. Lo scrittore colombiano Fabio Rodríguez Amaya ha detto che per afferrare l'identità caraibica, unitaria e molteplice, meta e provenienza, è necessario concentrarsi sulle idee di frontiera, di isola, di arcipelago, di diversità, di soglia verso l'ignoto o il nuovo, poiché il suo senso non è dato da una sola lingua, da una sola etnia, da una sola terra, ma dall'economia e da quell'insieme di rapporti generati mescolando quattro mondi verso l'ignoto e verso il nuovo.
Veniamo ora a quello che qui ci interessa, il rapporto, si diceva poc'anzi, tra il cimarrón e la religione, o ancor meglio, il rapporto che lega quest'uomo africano alla religione dei suoi avi o dei suoi compagni.
Esteban è consapevole che
Bisogna rispettare le religioni. Anche se non ci si crede molto.
Malgrado questa ammissione, mai si dichiarerà come homo religiosus. Mai nella vita, pur a stretto contatto con santeros e mayomberos, cercherà di affiliarsi in una delle Reglas africane.
Esteban esordisce con il dire che
Gli dei sono capricciosi e imprevedibili.
Rivela poi, fin dalle prime battute, di aver partecipato, a suo modo e per propria utilità, ad alcune cerimonie religiose africane, poiché
Gli dei più forti sono quelli africani.
Così, anche se egli si pone apparentemente nella sola dimensione di chi ha osservato un evento, un oggetto, come standone al di fuori, Esteban comincerà ben presto a raccontare di questi fatti.
Nei barracones (in quelli che lui ha conosciuto) esistevano, a suo dire, due sole religioni: la lucumí e la congo; quest'ultima distinta in cristiana e in judía, dice:
... tra il Congo giudeo e quello cristiano non c'era accordo. Uno era il buono e l'altro il cattivo.
Non parla Esteban di altre espressioni religiose tipicamente cubane, quali per esempio, la Sociedad Secreta Abakuá; non parla Esteban della Regla Kimbisa. Esteban non nomina altre Reglas: egli conosce esclusivamente la congo e la lucumí e la prima, tiene a dirlo, è di certo più potente e importante (ma intende dire pericolosa) della prima.
Lucumí e Congo, ossia Regla de Ocha o Santería (yoruba come il sangue del padre) e Reglas del Palo Monte (congo, l'etnia del patrigno). Gli schiavi africani arrivando a Cuba trovarono infatti una molteplicità di santi e li adottarono, non già giustapponendoli nel loro sistema religioso, ma reinterpretandoli e utilizzandoli come un mezzo per esprimere le loro concezioni religiose. Fu così che gli "dei africani in esilio" si trasformarono in potenze regnanti sui territori dei culti afro-americani.
Ma Esteban, si diceva, sembra estraneo a qualsiasi Reglas, sembra distante anche dalla santera e dalla mayombera e quando parla di esse lo fa sempre in terza persona plurale: essi facevano, essi preparavano, los congos eran, los lucumises estaban, ecc. Parla dei Congo e dei Lucumí come se lui personalmente non appartenesse a nessuna delle due, o forse come se... appartenesse ad entrambe.
I santi nel barracón erano presenze vere, non si celavano soltanto nei volti degli ijos de santos, ma erano pure rappresentati ed esposti, si ricorda Esteban, per mezzo di sculture lignee o pitture:
Ai vecchi Lucumí piaceva avere le loro figure di legno, i loro dèi. Le tenevano nelle baracche. Avevano tutte la testa grande. Erano chiamate oché. Eleggua lo facevano di cemento, ma Changó e Yemayá erano di legno e li facevano gli stessi falegnami. Sulle pareti delle stanze c'erano simboli di santo, fatti con carbone vegetale e gesso bianco. Erano lunghe righe e circoli. Benché ognuno rappresentasse un santo, dicevano che erano segreti. Questi negri tenevano tutto segreto. Oggi sono molto cambiati, ma prima la cosa più difficile era conquistarsi la fiducia di uno di loro.
Dei santeros, che egli vede spesso "... inchinati al suolo per più di tre ore a parlare nella loro lingua e a profetare", Esteban ci parla a proposito della festa di San Giovanni. Racconta:
Le feste nelle casas de santo erano bellissime. Ci andavano solo i negri. Agli Spagnoli non piaceva. Ma col passar degli anni la cosa è cambiata. Oggi si vedono anche babalawos bianchi con le guance rosse. Però prima era diverso perché la santería è una religione africana. Neppure le guardie civili, spagnole, ci si immischiavano. Passavano e tutt'al più chiedevano: "Che cosa succede?" E i negri rispondevano: "Siamo qua a celebrare il San Giovanni". Dicevano San Giovanni, ma era Oggún. Oggún è il dio della guerra. In quel periodo era il più conosciuto, nella zona. Sta sempre in campagna e lo vestono di verde o di violetto. Oggún Arere, Oggún Oké, Oggún Aguanillé.
Tra tutti gli orichas della Santeria, è per Oggún — dio del ferro e patrono dei guerrieri — che Esteban spenderà nella sua biografia più parole; è forse l'oricha che egli conosce meglio, anche perché nella zona Oggún era a quel tempo tra le figure della Santería più conosciute (così come dice lo stesso Esteban). Ed è quindi probabile che maggiori siano state le frequentazioni dell'ex-schiavo alle feste dedicate a questo oricha.
È nella divinazione che sta, secondo Esteban, la sostanziale differenza tra Lucumí e Congo, ci dice:
La differenza [...] è che il Congo risolve e il Lucumí profetizza. Sanno tutto dai diloggunes, che sono conchiglie africane con il mistero dentro.
Malgrado egli abbia premesso che la religione dei Congo sia più importante di quella dei Lucumí, egli sembra però provare una ferma simpatia per questi ultimi. Li descrive come pacificatori, quasi a contrapporre questa loro virtù all'inclinazione verso il maleficio (ndiambo) dei mayomberos bongos.
I vecchi Lucumí si chiudevano nelle stanze delle baracche con qualcuno e lo liberavano perfino dal male che faceva. Se c'era un negro preso dalla lussuria per una donna, il Lucumí lo calmava. Credo che lo facessero con il cocco, obi, che era sacro. È uguale al cocco di adesso che continua ad essere sacro e non si può toccare. Se uno sporcava il cocco, gli capitava una grande disgrazia. Sapevo che le cose andavano bene perché il cocco lo diceva. Comandava che dicessero Alafia perché la gente sapesse che non succedeva niente di tragico. Attraverso il cocco parlavano tutti i santi. Allora il loro padrone era Obatalá. Obatalá era un vecchio, almeno così dicevano, sempre vestito di bianco e non gli piaceva altro che il bianco. Dicevano che Obatalá aveva creato l'uomo e non so quante altre cose. L'uomo viene dalla Natura come lo stesso Obatalá.
Qui Esteban accenna alla divinazione con il cocco. Del frutto non si può fare a meno nella Santería. Esso, che appartiene a Obatalá, il creatore del genere umano, è il tributo che si paga agli dei in tutte le circostanze. È l'offerta e il cibo rituale degli orichas e degli antenati. Con la sua offerta hanno inizio tutti i riti della Regla, in quanto, come è noto, esso è l'ABC della divinazione lucumí.
È però proprio della religione dei Congo che Esteban comincia ad offrire, pur nella negatività del giudizio, le sue prime riflessioni. L'africanità mayombera che Esteban conosce a Flor de Sagua, l'ingenio presso il quale è stato venduto ancora bambino, è oltremodo forte, ovunque evidente. Qui tutto è nelle mani dei brujos, essi, dice,
... si impossessavano della gente. Con la faccenda delle profezie si guadagnavano la fiducia di tutti gli schiavi...
Il mayombe è talmente importante che
... persino gli stessi sorveglianti cercavano i loro favori. Credevano negli stregoni...
Questo, secondo Esteban, è il motivo per cui oggi non desta più meraviglia che un bianco creda nelle stesse cose dei negri. Diverse sono nel libro le occasioni in cui Esteban parla della nganga, il potente strumento del mayombero, contenitore ove risiede, insieme a tutte las cargas mágicas, il nfumbe, ossia lo spirito del morto.
Si metteva una ganga, cioè una grande pentola, in mezzo al cortile. Nella pentola c'erano le potenze e i santi. Il mayombe era un gioco utilitaristico. I santi dovevano essere presenti. Si cominciava a suonare i tamburi e a cantare. Si mettevano offerte nelle pentole. I negri pregavano per la loro salute, per quella dei loro fratelli e per la buona armonia. Si faceva enkangues con terra di cimitero. Con questa terra si facevano monticelli in quattro angoli, per rappresentare i punti cardinali. Nella pentola si metteva la fumaria, cioè un'erba, insieme a scarti di mais, per proteggere gli uomini.
Ma circa la preparazione di una prenda, che un testimone kimbisa di Lydia Cabrera descrisse alla grande antropologa come un mondo intero in miniatura essendovi cimitero, selva, fiume, mare, fulmine, vortice, sole, luna e stelle e che il mayombero può dominare, avendola dotata di tutti gli spiriti, Esteban, ricordando come durante la schiavitù ad essa venisse affidato anche il compito di vendicarsi del padrone allorquando uno schiavo veniva ingiustamente castigato, sarà ancora più preciso:
Per preparare una prenda che funzioni bene, bisogna raccogliere pietre, pali e ossa. È il punto più importante. I Congo, quando cadeva un fulmine, si imprimevano bene in mente il posto; passati sette anni andavano, scavavano un po' e tiravano fuori una pietra levigata per la cazuela. Anche la pietra dell'aura tiñosa andava bene per la potenza che aveva. Bisognava stare attenti al momento in cui l'aura tiñosa deponeva le uova. Ne deponeva sempre due. Uno lo si raccoglieva con cura e lo si faceva bollire un po'. Poi lo si riportava al nido. Lo si lasciava lì finché dall'altro uovo usciva il piccolo. Allora quello bollito, secco com'era, aspettava che andasse al mare. Perché l'aura tiñosa diceva che quest'uovo avrebbe anch'esso dato il suo frutto. Dal mare portava una virtù. Questa virtù era una pietruzza rugosa che metteva nel nido vicino all'uovo. La pietruzza aveva un potere magico molto forte. Dopo poche ore, dall'uovo bollito usciva il piccolo. Questo è sicuro. Con questa pietruzza si preparava la prenda; e non c'era da scherzarci su. Una prenda simile, non la poteva ereditare chiunque.
Quando uno stregone voleva far incantesimi, soprattutto malefici, sceglieva il martedì. I martedì sono i giorni del diavolo, per questo di martedì succedono tanti guai. Sembra che il diavolo, dovendo scegliere un giorno, si sia deciso per questo. In verità, ogni volta che sento questa parola, martedì, solo così, martedì, mi irrigidisco dentro, sento il demonio in persona. Se andavano a preparare una cazuela stregata dal mayombe judío, lo facevano di martedì. Così aveva più potere. La si preparava con carne di bue e ossa di cristiano. Stinchi, soprattutto. Gli stinchi vanno bene per i malefici. Poi si portava in un formicaio e si seppelliva lì. Sempre di martedì. Si lasciava nel formicaio per due o tre settimane. E un giorno, ancora di martedì, la si andava a dissotterrare. Allora si faceva il giuramento che consisteva nel dire alla prenda: "Io farò del male e farò il mio dovere verso di te". Questo giuramento lo si faceva a mezzanotte, che è l'ora del diavolo. E il giuramento del Congo era un contratto col diavolo. Con Endoqui. Il giuramento non era un gioco né una favola. Bisognava tenervi fede, se no uno poteva anche morire di colpo. Molta gente che muore così, senza malattia, è per castigo del diavolo. Dopo aver fatto il giuramento e dissotterrato la prenda, la si portava a casa, la si metteva in un angolo, e la si circondava di cose per alimentarla. Le si dava pepe di guinea, aglio e peperoncino rosso piccante, la testa di un morto e uno stinco avvolto in un panno nero. Questo involto, lo si poneva sulla cazuela e... guai a chi lo guardava! La cazuela così com'era quando arrivava a casa non serviva, ma quando le si mettevano intorno tutte queste cose, spaventava il demonio. Non c'era maleficio che non si potesse fare. È anche vero che la cazuela aveva la sua pietra di fulmine e la sua pietra d'avvoltoio, che erano il Male stesso.
Altri ancora, piuttotto ampi peraltro, sono nel racconto i momenti, in cui Esteban si sofferma sulla ganga. Sembrerebbe che è questo un argomento che assai ben conosce. Forse, tra tutti, quello che egli conosce meglio. E non è un caso. Spesso ripete di aver avuto amici congo, anche nella guerra. Parla molto della nganga mayombera, non dice nulla del corrispettivo santero, la sopera.Sempre a proposito della ganga, Esteban racconta a Barnet:
Nella religione dei Congo si usavano i morti e gli animali. I morti li chiamavano nkise e le bisce emboba. Preparavano cazuelas che camminavano e tutto: questo era il segreto della stregoneria. Si chiamavano ngangas. Tutti i Congo avevano le loro ngangas per il mayombe. Le ngangas erano legate al sole. Perché il sole è sempre stato la forza e l'intelligenza degli uomini. Come la luna lo è per le donne. Ma il sole è più importante perché è lui che dà vita alla luna. I Congo facevano fatture con il sole quasi tutti i giorni. Quando avevano qualche guaio con qualcuno, lo seguivano per un sentiero qualsiasi e raccoglievano la polvere che calpestava. La conservavano e la mettevano nella ganga o in un angolino. Via via che il sole calava, la vita della persona si spegneva. E al tramonto del sole la persona era morta. Lo dico perché è un fatto che l'ho visto molte volte durante il periodo della schiavitù.
Ad Esteban non piace conoscere in modo eccessivo le cose, come egli dice, della vita ajena, lo ripete spesso, e oltre al proprio sé, al di fuori di esso, per Esteban vi sono soltanto altri da sé. Egli non appartiene apparentemente a nessuno! Tutta questa atmosfera di magia nera crea in Esteban, anche ora nella sola dimensione del ricordo, uno stato di tensione emotiva che lo porta a passare oltre, a raccontare d'altro, convinto come è che
Se uno ci pensa bene, i Congo erano assassini. Ma se ammazzavano qualcuno era perché anche a loro avevano fatto qualche torto.
Esteban è assai preoccupato di far comprendere quella che, secondo il suo punto di vista, è, oltre alla divinazione, la sostanziale differenza tra la religione dei Congo e quella dei Lucumí. Sostiene:
Neppure il Lucumí e il Congo andavano d'accordo. Li dividevano i santi e la stregoneria.
È qui il punto. Santi e stregoni. La differenza è tra chi lo attira e chi invece egli avverte come pericoloso. Quella magia, cristiana o judía non importa, è un qualcosa di cui temere. E per un ex-schiavo, che non ha conosciuto altra realtà al di fuori di quella che da sempre ha visto dal primo momento dell'attivarsi della coscienza, è questo un peso che va ad aggiungersi a quello del lavoro nei campi, all'odio che legge negli occhi del mayoral, alle torture che si subiscono (descritte con crudezza nelle pagine della sua biografia).
Lui con la brujeria non vuole avere a che fare. E dire che gli capita anche una donna bruja, una tale Ana!
Quella donna — dice — mi piaceva. Era bella e azzurrina; una di quelle mulatte azzurrine che credono solo in se stesse. Si chiamava Ana. Per lei restai a vivere là. Ma con il tempo mi sono stancato. Questa Ana mi spaventava con le sue stregonerie. Tutte le notti era la stessa storia: spiriti e streghe. Allora le ho detto: "Non voglio più stare con te, strega". Lei se ne è andata per la sua strada e non l'ho più vista.
Tutti sono minacciati dalla potenza dei brujos, e
Gli unici che non avevano problemi erano i vecchi africani. Erano speciali e bisognava trattarli con rispetto perché sapevano tutto della religione.
Il Congo, brujo, mayombero, distante e così vicino da essere a gomito di giaciglio nel barracón o corpo di donna nello stesso letto, è un problema che si aggiunge ai mali della esclavitud e alle condizioni miserabili (seppur vissute da Esteban con esemplare dignità) di coloro che, come tutti gli ex schiavi di Cuba all'indomani dell'abolizione della schiavitù continueranno a chapear, agotar, botar, limpiar, tumbar o cortar caña in quegli stessi ingenios dove erano stati schiavi. Per chi poi non ha mai razionalizzato nemmeno il perché della propria situazione ("Ci sono cose che non mi spiego della vita"), per chi come Esteban, e per tutti "le creature" nate "in un infermeria, dove portavano le negre incinta affinché partorissero", che hanno sempre vissuto il viaggio dall'Africa come racconto, che nulla sanno di ciò che è successo, del perché vi siano schiavi negri nei barracones, dueños bianchi e mayorales, l'unica via ipotizzabile è la fuga, ossia farsi cimarrón.
Esteban confessa a Barnet:
La vita era dura e il fisico si rovinava. A chi non scappava giovane in montagna, a fare il cimarrón, non restava che essere schiavo. Era preferibile restare solo, disperso, che nel porcile con tutto lo schifo e il putridume.
Esteban accetterà così la propria solitudine come l'unico strumento per essere davvero libero e per sfuggire a tutto. E così, per lunghi anni (ben oltre comunque la stessa abolizione della schiavitù) rimarrà rintanato nel monte, non fidandosi di nessuno, ripetendosi: "Cimarrón con cimarrón, vende cimarrón", ma con una grande e unica certezza che lo accompagnerà nel corso di tutta la sua vita:GLI DEI PIÙ FORTI SONO QUELLI AFRICANI.
Relazione presentata in occasione del "VI Taller de Antropología Social y Cultural Afro Americana" (6-9 gennaio 2002, Casa de África, La Habana, Cuba; Comisión # 2 Tema "Cultura, Identidad y procesos de Resistencia", martedì 8 gennaio)
 Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2009 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados



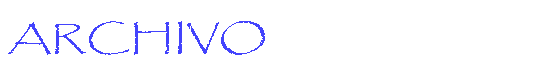
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()