Ci sono viaggi d'iniziazione. Il destino porta a convergere in un'isola caraibica strade di risaia e di pampas e questo cambia le vite.
Nel gennaio del 2004 mi trovavo a L'Avana, invitata dal Museo Casa de África ad esporre, nel Convento di San Francisco, una serie di dipinti dedicati alla Santería, il culto sincretico che unisce i santi cattolici alle divinità yoruba. Già quella possedeva tutte le caratteristiche di una bella esperienza ma, come dicono i cubani, a volte Elegguá, il giovane dio capriccioso che tiene strette le chiavi del futuro, decide di aprirci le porte. La casa scelta per me era quella di Alberto Granado, il miglior amico di Ernesto Che Guevara.
Un giorno suo figlio, anche lui Alberto, direttore del Museo, mi chiede di trasferirmi da loro. Entro così a far parte di una grande famiglia che mi accoglie con naturalezza in cucina, come se appartenessi al loro mondo da sempre. Un attimo e subito mi trovo a preparare il tavolo e lavare l'insalata. Ma l'emozione rimane, ed è giustificata, nell'attesa di conoscere il compagno d'avventura di un mito.
Appena lo vedo arrivare dal giardino, subito mi ricorda un contadino della nostre colline.
L'autore di Con el Che por Sudamérica, diario parallelo alle Notas de viaje del giovane Ernesto, scritti durante il famoso viaggio in motocicletta attraverso l'America Latina che ad entrambi cambiò la percezione dell'esistenza ed il destino, è un ometto col viso solcato da mille rughe e anche gli occhi sono minuscoli, ma vivissimi e ridenti.
"Benvenuta, figlia mia" — dice abbracciandomi e in quella stretta entrambi leggiamo i segni di un affetto istintivo e profondo.
"Italiana, vero?", ancora non gli ho risposto e già mi canta "La bella Gigogin" e "Piemontesina bella".
Non riesco a crederci. Consapevole e divertito di stupirmi, termina con una filastrocca:
"Chiccolino, chiccolino, tira fuori il tuo capino... ".
Lo guardo ammutolita. È vero che a Cuba sono labili i confini tra la realtà e il sogno, ma tutto avrei potuto prevedere tranne che il miglior amico del Che parlasse l'italiano e capisse perfettamente il piemontese!
Papà Granado spiega che a Cordoba, nella sua Argentina, gli emigranti erano molti e lui è cresciuto tra loro. Per questo ne conosce le tradizioni, i balli, i canti e la cucina.
"Che miracolo la bagna caoda! Si, piaceva anche ad Ernesto!"
E subito il mito si ridimensiona ed è come se condividesse i nostri discorsi nella grande cucina caraibica, che è un porto di mare di familiari, parenti ed amici, personaggi che appaiono e scompaiono come nella casa dei Buendía in Cent'anni di solitudine, solo che qui gli uomini si chiamano Alberto e le donne Delia.
Qui certo il Comandante toglierebbe la divisa e sarebbe uno di noi.
"Su una cosa non eravamo d'accordo, io ed Ernesto. Sul libro Cuore. Non so come non facesse a piacergli Garrone, ma lui che amava Giulio Verne, lo considerava un libro troppo morbido, con troppe lacrime inutili!"
Nulla c'entra il racconto di questo patriarca dall'animo bambino, con le immagini del Che vendute come gadget, riprodotte a milioni su magliette e berrettini e spogliate del senso profondo di giustizia e libertà che Ernesto aveva saputo, coerente e caparbio, trasformare in progetto di vita.
"È questo il Guevara di cui, da anni, parlo ai giovani. Non il mito segregato in un olimpo distante, — dico sempre —, ma un ragazzo come voi, disposto a lottare per un'ideale".
Nei giorni in cui il vecchio Granado è sotto i riflettori del Festival di Cannes, e tutti i giornali e le televisioni raccontano di lui, ultimo, meraviglioso testimone di un leggendario viaggio della consapevolezza e dell'impegno attraverso le sofferenze di un continente, sono tornata volentieri col pensiero in cucina per rivivere un momento speciale di gioia e commozione.
È sera. Sul tavolo, immancabile, una bottiglia di Habana Club. Papà Granado, è stranamente taciturno. Da, due giorni aspetta notizie del film diretto da Walter Salles e prodotto da Robert Redford, di cui è stato un consulente preciso ed indispensabile. Lo proiettano al Sundance Festival di Salt Lake City dove, per una storia di permessi negati dall'Ufficio d'Interessi Nordamericani, non ha potuto andare.
Il "Gitano Sedentario" torna sempre alla sua Isola
Squilla il telefono. È l'aiuto regista. Dice che I diari della motocicletta ha ottenuto un trionfo d'applausi e una "standing ovation" interminabile dedicata a lui e ad Ernesto Guevara. I piccoli occhi si riempiono di lacrime, ma subito si ricompone e mi chiede di passargli il bicchiere.
"¡Que buena ocasión para hacer un brindis!" — dice, nel suo modo abituale di ringraziare la vita.
Poi s'informa:
"E a Roberto è piaciuto?"
Roberto è Robert Redford, anche lui assorbito dallo spirito di una casa dove tutti vengono chiamati per nome. Così Salles è semplicemente Walter e Minà, che ha girato un documentario sul film, In viaggio con Che Guevara, è per tutti Gianni. Anche i due attori, il messicano Gael García Bernal, l'interprete del giovane Ernesto e l'argentino Rodrigo de la Serna che coi suoi baffetti radi assomiglia al Granado trentenne come una goccia d'acqua, non sono che Gael e Rodrigo, com'è giusto sia con persone di famiglia.
Papà Granado, confessa che in un unico, interminabile attimo di nostalgia, ha rivissuto tutte le tappe del viaggio: la partenza dal cortile della sua casa di Cordoba a bordo della Poderosa II, una Norton 500 destinata a passare alla storia anche se presto li avrebbe abbandonati, le avventure con le donne, l'asma di Ernesto, la scoperta dell'immensa bellezza dei paesaggi e dell'immensa miseria della gente. Sei mesi, dal dicembre del 1951 al maggio del 1952, attraverso l'Argentina, il Cile, il Perù, la Colombia, il Venezuela, con lo zaino in spalla, a piedi, clandestini a bordo di una nave, o marinai improvvisati come appaiono in una foto sgualcita appoggiati ai remi sulla Mambo-Tango, una zattera rudimentale costruita per loro dai lebbrosi che avevano a tutti i costi voluto raggiungere nel lebbrosario di San Pablo, sperduto nell'Amazzonia peruviana. Entrambi esperti di lebbra, Ernesto studente in medicina e Alberto biochimico, lì avevano lavorato e curato i pazienti, avevano mangiato e giocato con loro. E lì Ernesto per festeggiare il suo venticinquesimo compleanno aveva deciso di attraversare a nuoto il Rio delle Amazzoni,
"Ernesto era abituato alle sfide. L'ho conosciuto che aveva quattordici anni e io venti, ma non ho mai avvertito la differenza di età. Non ho mai visto un ragazzo leggere così tanto! Era compagno di classe di mio fratello Tomás e, per via dell'asma che lo torturava, era gracile e mingherlino. Ma quando giocava a rugby, non lo fermava nessuno. L'avevamo soprannominato Fuser, il furibondo Serna, dal cognome di sua madre, una donna battagliera".
Fuser e Mial, contrazione affettuosa di Mio Alberto, i diminutivi con cui erano soliti chiamarsi tra loro, spiccano ora sullo schermo del computer che papà Granado utilizza con abilità sorprendente, per siglare una fratellanza di cuore e un sodalizio senza tempo.
 Nella stanza dove questo piccolo grande uomo di 82 anni ama rifugiarsi per rispondere alle tante lettere che gli arrivano da tutto il mondo, ascoltare i tanghi struggenti del suo Gardel e dar un ordine alle proprie riflessioni, le pareti, persino quelle dell'armadio, sono tappezzate di ritratti del "Che" coi suoi occhi fieri che guardano lontano, e del Che parlano i libri color paglierino allineati negli scaffali e le fotografie sbiadite e le lettere, protette dal vetro della scrivania. Dopo il viaggio attraverso il Sud America, le loro strade si erano divise. Alberto aveva continuato a dedicarsi ai lebbrosi in Venezuela ed Ernesto aveva scoperto la Rivoluzione. Ma nel 60, lo aveva voluto con lui a Cuba dove ora sono famose le sue ricerche e i suoi interventi nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame. Gli scrisse un'ultima lettera prima del viaggio senza ritorno in Bolivia e questa volta lo chiamò Gitano Sedentario, come se volesse invitarlo a fermarsi sull'Isola, a dispetto del suo spirito vagabondo. Questo infaticabile vecchio bambino non ha mai smesso di esplorare il mondo per continuare a nutrire i loro sogni comuni di scoperta, ma all'Isola è sempre tornato portando in dono, ogni volta, una goccia in più di energia, di saggezza e di quella contagiosa gioia d'esistere che ha il potere di cambiare nel profondo chi, come me, ha avuto la fortuna d'incontrarlo. Per questo, grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Nella stanza dove questo piccolo grande uomo di 82 anni ama rifugiarsi per rispondere alle tante lettere che gli arrivano da tutto il mondo, ascoltare i tanghi struggenti del suo Gardel e dar un ordine alle proprie riflessioni, le pareti, persino quelle dell'armadio, sono tappezzate di ritratti del "Che" coi suoi occhi fieri che guardano lontano, e del Che parlano i libri color paglierino allineati negli scaffali e le fotografie sbiadite e le lettere, protette dal vetro della scrivania. Dopo il viaggio attraverso il Sud America, le loro strade si erano divise. Alberto aveva continuato a dedicarsi ai lebbrosi in Venezuela ed Ernesto aveva scoperto la Rivoluzione. Ma nel 60, lo aveva voluto con lui a Cuba dove ora sono famose le sue ricerche e i suoi interventi nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame. Gli scrisse un'ultima lettera prima del viaggio senza ritorno in Bolivia e questa volta lo chiamò Gitano Sedentario, come se volesse invitarlo a fermarsi sull'Isola, a dispetto del suo spirito vagabondo. Questo infaticabile vecchio bambino non ha mai smesso di esplorare il mondo per continuare a nutrire i loro sogni comuni di scoperta, ma all'Isola è sempre tornato portando in dono, ogni volta, una goccia in più di energia, di saggezza e di quella contagiosa gioia d'esistere che ha il potere di cambiare nel profondo chi, come me, ha avuto la fortuna d'incontrarlo. Per questo, grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Maria Giulia Alemanno, pittrice e giornalista,
vive e lavora a Torino e a Crescentino (Vercelli).
Collabora con scritti e disegni alla Stampa.


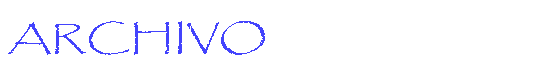
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()