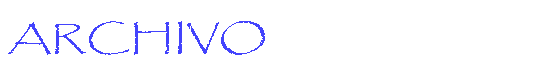Kabiosile Ignacio Piñeiro
Ramón Fernández-Larrea — Traduzione e note a cura di: Ferruccio Paoletti
Sotto il sole, in bocca il gusto del salino, Ignacio ripercorre a ritroso la città. È la stessa, eppure è diversa da quella che conoscerò ottant'anni dopo; quella che è cresciuta davanti ai miei occhi di provinciale sbigottito; quella che poi è andata crollando, fra lampi di nostalgia. E al cospetto dei loro poderosi canti, quelli di Ignacio Piñeiro e quelli della città — che oggidì sono finalmente una medesima cosa — io subii un'evoluzione identica a quella del ritmo stesso che egli seppe elevare ad altezze inimmaginabili: il Son cubano, nato fra le montagne che videro la mia infanzia conturbata, e che poi si sarebbe messo in viaggio, a ogni passo gonfiando le sue arie di suoni nuovi, fino ad arrivare a quella capitale che già all'epoca si distingueva sul resto dell'isola; e nelle mani di Ignacio Piñeiro avrebbe trasformato lentamente le proprie cadenze e le proprie formule, il sapido condimento dei suoi canti, i suoi ritornelli mossi da un picaresco vorticare, e tutta la sua saggezza, col salino e le voci ferite dei cabildos[1], e i negri del porto che conducevano vita grama, portando sulle spalle tutte le cose peggiori di questo mondo.
Perché Ignacio Piñeiro — venuto alla luce il 21 maggio 1888 nel quartiere di Jesús María, l' "accademia" di musica popolare più grande del mondo, e con un'inaudita densità di popolazione d'origine africana — si trasferì, ancora bambino, a un altro barrio ugualmente dominato dai suoni: Pueblo Nuevo. In quei luoghi si nutrì dei canti tristi dettati dal tamburo. Lì s'abbeverò ai riti antichi e primitivi, al ritmo sanguigno del guaguancó — che è autentica filosofia, tramandata oralmente con l'incanto del tuono — e al culto dell'umanità, dell'amicizia, della musica come unica insostituibile libertà. Una fuga verso sfere ove si diventa praticamente intoccabili. Per questo, forse, scrisse e cantò questa strofa d'amore per una donna, nella quale proclamò quella che, per l'eternità, sarebbe stata la sua strada:
... Nació en el mismo solar que yo nací,
es buena como yo,
le encantan las melodías de los suburbios
y da su corazón
cuando siente este cantar.
El guaguancó es lo más bueno que convida Dios...[2]
Più avanti avrebbe poi affermato e ripetuto: la rumba la manda Dios, ay qué buena está.
Era il 1906, e quella verità che gli fluiva nell'anima come un fremito di gioia l'aveva ormai appresa, cantando nel gruppo di clave e guaguancó "Timbre de Oro", e successivamente ne "Los Roncos", la passione più duratura della sua esistenza, mentre le sue mani toccavano cose ben più mortali che però servivano ad alimentare il corpo. In tal modo passò attraverso i mestieri più svariati, lavorando come portuale, fonditore, nelle fabbriche di botti e di tabacco e, soprattutto, come muratore, attività in cui si rese maestro. I rivestimenti e le piastrelle del Capitolio Nacional portano ancora il marchio del suo impegno.
Tuttavia quelle umane faccende non rappresentavano che "tutto il resto". Era la musica il fuoco che ne illuminava ogni gesto. Iniziò così a prender forma ciò che gli riempiva il petto, le storie a cui assisteva o di cui sognava, e quelle frasi e modi di dire che più tardi sarebbero diventati pane quotidiano nelle sentenze di popolo. Ancora era piena rumba, solamente rumba, le ancestrali evocazioni di scongiuro tra il fragore delle pelli di tamburo e l'aguardiente, la luce del rispetto più profondo verso gli orishas benefattori, santi trasportati dal verde cuore dell'Africa al nuovo mondo che sprizzava dolore e sangue.
Forse è da quella genuina, sincera vicinanza che scaturirono due suoi temi, colorati dal fascino discreto e un po' bizzarro per le divinità: "Mayeya, no juegues con los santos" e "En la alta sociedad", primo son — questo — a esser cantato "in lingua" (qualche anno dopo) da una donna, María Teresa Vera, quella stessa che avrebbe portato tanto e tanto di buono nella sua vita.
Così Dio veniva già da allora mescolato ad argomenti tipici degli uomini. Il Dio dei bianchi, quello che i conquistadores avevano infuso nelle vene della stirpe rubata ad altri paesaggi. E lui aveva dato a quel Dio quello che era di Dio, e alla rumba quello che era di una simile esplosione dello spirito:
... Rumba: ¿qué le has hecho a mi pobre mujer?
Per questo un giorno, nella semplicità dei suoi divertimenti e delle sue sorprese, fu capace di dire senza dar scandalo:
Mayeya,
no quiero que me engañes,
respeta los collares,
no juegues con los santos.
No pretendas engañarme con ese cuento
porque todos en Cubita nos conocemos
per poi liberare una verità pura e levigata come una pietra di ruscello:
el que no lleva amarillo, se tapa con azul
e rifinire l'avvertimento, apparentemente solenne, attraverso quell'atmosfera indulgente, ma sacra al tempo stesso, che contraddistingue il Son:
Venga ori baba,
delante e 'los santos no debes jugar...[3]
A partire dal 1920 un qualcosa di nuovo smuove le pietre della città. In un primo tempo nascosto, visto di mal occhio, zittito da quella società bianca che in seguito sarebbe stata destinata a patirne per contro l'inevitabile incantesimo. Il Son era arrivato nella capitale, ancora col suo odore di monti e altipiani, dei tres suonati nelle plaghe paludose[4], delle mandibole d'asino[5], con un linguaggio troppo asciutto e scarno per quella baldoria che le notti all'Avana invece reclamavano. E il ritmo di stanche litanìe era in procinto di incontrare, proprio all'Avana, il suo artefice, come per altro verso lo trovò in Miguel Matamoros ai piedi delle ridenti colline di Santiago de Cuba.
Piñeiro, che aveva già fatto parte di un altro coro de clave[6], il Renacimiento, imparò a suonare il contrabbasso e a marcarne i colpi tellurici, come ondate possenti, insieme alla stessa María Teresa Vera, segnata anch'essa — fin dal 1916 — da quelle splendide sonorità. E divenne allora musicista in pianta stabile di un gruppo pioniere, il Sexteto Occidente, cominciando allora a rimpinguarne il repertorio con alcune creazioni proprie, che già recavano con sé pulsazioni nuove.
E in quella fucina affilò le armi. Fiutò il futuro cui andava incontro il nuovo ritmo, con quello scoppio di dolcezza e di piccante sparso in tutto il nostro paese che si sarebbe poi esteso ad altri, insinuandosi nelle ossa e contagiando quanti ne ascoltavano il richiamo.
Con l'Occidente viaggiò alla volta di New York nel 1926, ove la formazione incise una ventina di buoni sones. Dieci portavano la sua firma, quel suggello indelebile che l'anno seguente gli avrebbe aperto le porte del tempo allorché fondò la sua migliore creazione: il Sexteto Nacional — in fraterna concorrenza col Sexteto Habanero. Con tale gruppo, ricorrendo alle sue abili arti di mago, andava a placare la sete di musica dei cubani: costruttore di cadenze irresistibili, padrone d'una grazia senza limiti, primo, nel tessuto cittadino, a dimostrarsi l'autentico "civilizzatore" del ritmo. Un Son con tutta la grinta e i mormorii di una città aperta all'allegria mondiale.
Ma se con l'Occidente di María Teresa aveva lanciato il guanto di sfida con brani (ora classici) come "Tápame que tengo frío", "Cabo de la guardia" e "Yo no tumbo caña", col proprio gruppo avrebbe di lì a poco scritto la pagina "totale" del futuro corso.
Puntando completamente sul suo incredibile istinto, lanciò la massima [in quel Son ineffabile e cullante che è "Suavecito", ndt] che colloca il nuovo ritmo... in paradiso, paragonandolo alle prelibatezze celestiali:
... El son es lo más sublime
para el alma divertir,
se debía de morir
quien por bueno no lo estime...[7]
E nacquero così 327 sones, come colpi inferti al futuro, come germi nel sangue del popolo, destinati a generare il regno dell'allegria; come 327 sorrisi per vivere.
Forse il più famoso è quello in cui si racconta un delirante episodio che quasi sfocia nella profonda gastronomia:
... Salí de casa una noche aventurera
buscando ambiente de placer y de alegría,
¡ay mi Dios, cuánto gocé!
en un sopor la noche pasé
giungendo poi a una locanda situata fuori l'Avana, sulla strada per Matanzas, Catalina de Güines:
En Catalina me encontré lo no pensado,
la voz de aquel que pregonaba así...
Échale salsita, échale salsita.
E il brano, che s'intitola per l'appunto "Échale salsita", inaugurò l'impiego delle chiavi più segrete per esprimersi, misteri di un'essenza che passa dal... pentolone al ballo, e una propaganda fra le più categoriche di quest'universo, per quanto poi quel luogo sia oggidì in rovina e pieno di fantasmi:
En este cantar propongo
lo que dice mi segundo:
no hay butifarra en el mundo
como la que hace El Congo...[8]
"Avanizzando" il Son squarciò l'orizzonte, divenne universale. George Gerswhin mise alcune battute di quella salsita nella sua "Cuban Ouverture", e la mostrò al mondo come un inconfondibile tesoro.
Ignacio è una delle basi irrinunciabili per poter capire quest'isola che è sopravvissuta a tristezze umane e divine. Pose stabilmente le fondamenta di un'espressione che poi con orgoglio ha condotto molto distante. E, come Matamoros, ha lasciato un'abbondanza di frasi e di suoni che mi difendono dall'orrore, ogni volta che escono dal profondo del mio cuore — per imprimersi alla maniera di quelle nenie che ogni madre ha cantato alle frontiere del sogno — i canti saturi di sapienza e splendore: "Échale salsita", "Esas no son cubanas", "Guanajo relleno", "Bardo", "Entre preciosas palmeras", "Las cuatro palomas", "La cachimba de San Juan", e "Suavecito" — il tema immortale che portò in prima esecuzione alla Fiera Universale di Siviglia nel 1929, nel pieno fulgore del suo gruppo trasformato ormai in Septeto Nacional con l'inserimento della tromba.
Dal 1947 visse in un'umile casa di un altro quartiere popolare, San Miguel del Padrón. E lì andò incontro alla morte il 12 marzo del 1969 — presumo protetto dal simbolico riparo di un tres.
Gli uomini sono soliti circondarsi di bandiere e scudi; segni d'appartenenza; astri di quei luoghi che più amano in questo mondo, per nascita o per scelta.
Se io avessi uno scudo non lo riempirei di ori o armi assurde in campo rosso. Lì ci starebbe invece, se fosse possibile, tutta la musica che ha lasciato per l'eternità Ignacio Piñeiro. L'inconfondibile suono di quel Septeto che ha avvolto i timidi passi di ballo dei miei nonni e dei miei genitori, e che io stesso canto mentre viaggio sotto un altro sole, perché non possano più ferirmi terre incomprensibili, assenze innominabili.
Più che una bandiera è il mio amuleto, la forma immensa del sangue che mi culla.
La mia voce definitiva.
Note
1. Con cabildos [sorta di "capitoli", sedi di consiglio] si denotano i raggruppamenti di zona, strutturati in forma di vere e proprie società organizzate, nelle quali si riunivano le popolazioni nere, soprattutto in alcune zone periferiche dell'Avana come La Regla o Guanabacoa, o a Matanzas e Cárdenas. Fu nei cabildos che, alla fine del XIX secolo, si sviluppò il fenomeno delle sette segrete Abakuá.
2. "È nata nello stesso solar [ovvero un gruppo di case popolari unite da uno stesso patio, ndr] in cui sono nato io / è buona come lo sono io / la affascinano le melodie dei sobborghi / e dà tutto il suo cuore / quando sente questo canto. / Il guaguancó è la cosa più bella a cui possa invitarci Dio."
3. "Rumba: che cosa hai fatto alla mia povera moglie?" ... "Mayeya / non voglio che m'inganni / rispetta le collane [allusione ai sacri collares de mazo che si portano, ciascuno con un colore dedicato, in onore degli orishas; ndr] / non giocare coi santi. Non tentare d'ingannarmi con queste storie / perché a Cuba ci conosciamo proprio tutti" ... "Chi non porta il giallo si copre comunque d'azzurro [sempre in riferimento all'adorazione di questa o quella divinità; ndr]" ... "Su, ori baba / di fronte ai santi non devi giocare."
4. Tres manigüero nel testo: la "manigua" è l'impervia zona di boscaglia situata ai margini delle catene montuose, nelle zone interne dell'isola, e così come il "Monte" simboleggia quel terreno che storicamente accolse i negri fuggiaschi, proteggendoli dalla persecuzione e diventandone profondo ricettacolo di tradizioni.
5. Quijada de burro: si tratta di un primitivo strumento musicale (cfr. Orovio), letteralmente costituito dalla mandibola di un cavallo o di un mulo. L'osso dev'essere completo di denti, che effettivamente "suonano" non appena lo si scuote, o sfrega, o lo si percuote con bacchette.
6. I "coros de clave" o "cantos de clave" costituiscono un vero e proprio genere cantato, a sé stante ma molto affine alla rumba, creato da gruppi popolari nei quartieri adiacenti alle zone portuali dell'Avana, e poi esteso anche alle città di Matanzas, Cárdenas e Sancti Spíritus.
7. "Il Son è la cosa più sublime / per divertire l'anima. / Dovrebbe morire / chi non lo considera bello".
8 . "Uscii di casa in una notte d'avventura / in cerca d'un luogo di piacere e d'allegria / oh Dio, quanto mi sono divertito! / trascorrendo la notte nel sopore" ... "A Catalina ho trovato una cosa che non m'aspettavo / la voce di un tale che annunciava: / mettici della salsa, mettici della salsa" ... "In questo canto dichiaro / ciò che dice il mio secondo: / non esiste salsiccia al mondo / come quella che produce il Congo".
 Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2019 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados