La vita di Ibrahim Ferrer è stata come uno dei boleros che con la sua voce vellutata e un po' antica aveva riportato alla luce.
Una vita iperbolica, senza mezze misure, come i sentimenti e le passioni di brani come "Perfidia", "Quiereme mucho", "Dos Gardenias", "Silencio", colonne sonore di una Cuba che sembrava definitivamente passata fino a quando Buena Vista Social Club non l'ha — anche un po' violentemente — riportata alla luce.
Adesso, anche la voce di Ferrer si è spenta, all'Habana, di ritorno da un tour in Europa. Una gastroenterite sembra essere la causa della morte, ma forse più di tutto la stanchezza di 78 anni vissuti con fatica e a fasi alterne dai picchi esasperati. Le biografie raccontano di un musicista eccezionale, di un talento fuori dal comune che aveva iniziato giovanissimo la sua carriera musicale a Santiago de Cuba, cantando al seguito di nomi celebri come Benny Moré, Pacho Alonso, Chepín Choven.
Quello che non raccontano, o che suggeriscono appena, sono gli oltre trent'anni passati nel silenzio totale, nella miseria più umile, lustrando scarpe per le strade fangose di Centro Habana, raccoglieno rifiuti, cercando di tirare avanti inventando, come la stragrande maggioranza dei cubani, evitando accuratamente di usare ancora lo strumento che gli aveva permesso di assaggiare i fasti di una vita persa assieme al trionfo della rivoluzione: la voce.
Ferrer era convinto di essere vittima di una sorta di stregoneria e pensava che mai più avrebbe potuto fare quello che meglio gli riusciva, cantare e cantare boleros, genere caduto un po' in disgrazia dagli anni settanta ad oggi.
Poi di nuovo la celebrità, come in un bel sogno, i più grandi teatri del mondo, vestiti di lino bianco di sartoria, aerei, la gente che ti saluta nei vicoli dell'Habana, e poi il Grammy, la riscossa.
Ho incontrato Ferrer all'inizio del vortice di successo generato da Buena Vista. Non da giornalista, ma da Iyawo (iniziata alla religione più praticata a Cuba, la santeria. Fu lui a venirmi incontro alla fine di un concerto milanese. Mi aveva vista, tutta vestita di bianco, e Voleva la mia benedizione, da buon credente nella Regla de Ocha. Fu in quell'occasione che mi raccontò che tutta la sua fortuna la doveva a San Lázaro, a cui era consacrato, e al quale non aveva mai smesso di dedicare offerte e regali, anche quando faceva fatica a racimolare un pasto al giorno.
Babalu Ayé (il nome yoruba del santo) lo aveva premiato e lui questo non lo avrebbe mai scordato. Mi mostrò il bastone africano, quello di cui parla nel film, un piccolo idolo di ebano, che portava sempre con sé, quasi un pegno agli spiriti degli antenati.
Insieme a Ruben González, Ibrahim Ferrer era forse il talento più autentico e immutato nel tempo di tutta la combriccola messa insieme da Ry Cooder. A differenza di altri membri del gruppo (come Compay Segundo, ad esempio) Ferrer non solo aveva conquistato il mondo con la sua voce incantatrice e il suo stile incredibilmente elegante di interpretare i boleros e i son della tradizione, ma aveva riconquistato anche Cuba, il palcoscenico più difficile per gli artisti del suo genere. Mentre la fama di Compay, di Ochoa o dell'intramontabile Portuondo si è limitata in un certo senso alla facciata ufficiale, quella di Ferrer e di González aveva toccato il cuore dei cubani, forse grazie alle loro personalità autentiche e alle loro storie di umiltà mai perduta e di gratitudine alla vita per i tardivi riconoscimenti ottenuti.
Musicalmente Ferrer era stato capace di ridare lustro a brani che i cubani consideravano ormai musica per vecchi nostalgici ed era stato capace di approfittare in pieno dell'opportunità ottenuta con Buena Vista per fare al meglio ciò che aveva sempre fatto.
Rimane come un testamento musicale il disco che Ferrer aveva appena presentato a Barcellona, Ay Candela, che si chiude con un guaguancó, un classico della rumba afrocubana, intitolato "Todavia me queda voz" ("Mi rimane ancora voce").


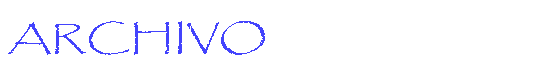
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()