
Cuba

Una identità in movimento
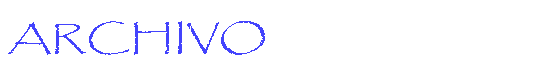
|
|
Cuba |
|
|
Una identità in movimento | ||
|
| ||
Afroavana dei Santi
Danilo Manera
I tamburi sacri o batá per la cerimonia cui assisto sono tre e si chiamano iyá il maggiore, che ha anche dei sonagli, itótele quello medio e okónkolo il più piccolo e acuto. Sulle doppie membrane battono instancabili e abilissime le mani di tre musicisti di professione: hanno suonato persino al Tropicana, ma questa è un'occasione privata, la festa per la "discesa del santo" su un figlioccio del padrone di casa, che diventa iyawó, iniziato alle sacre cose della santería cubana. Ai tamburi sono stati offerti dei cibi perché dentro di loro abita, possessore di un segreto inviolabile, Añá, un orisha, cioè una di quelle divinità nate da mitici antenati africani che gli schiavi negri hanno portato con sé sulla Grande Antilla. Per ogni orisha c'è uno specifico ritmo, un'invocazione, una litania corale guidata da Ángel, il capo cantore. Il festeggiato, in candide vesti e scalzo, ha eseguito per mesi i complessi preparativi del rito e ora ci si attende che quello che sarà il suo orisha si impossessi di lui. Tutt'intorno ballano decine di persone d'ogni età e sfumatura di colore: non solo invitati, ma anche credenti di passaggio, che sentono la liturgia dalla strada ed entrano.
Testo tratto dal volume fotografico di Graziano Bartolini La Habana como un chevrolet (Arci Solidarietà, Cesena 2000), pp. 80-87
Per fortuna, nessuno mi fa caso e provo a inserirmi nel flusso imitando gli altri. L'intercessione di Moraima mi ha permesso di trovarmi anch'io qui, in un quartiere popolare dell'Avana, in una casa modesta, agghindata per l'occasione. Sembra persino che sia stata svuotata da quel che conteneva per far spazio a tre sole realtà: la sala e il patio gremiti di gente che canta e danza al suono dei batá, la cucina con bevande fresche per il calore del pomeriggio tropicale e una stanza trasformata in una sorta di enorme altare o presepe, tutto rosso e bianco, dedicato a Changó, virile signore guerriero del fuoco e del tuono, mescolato dal sincretismo con la martire Santa Barbara di Bitinia. Ci sono statuette, asce di legno, vassoi colmi di frutta, collanine, persino una spada tra piatti di quimbombó. Gli ospiti si inginocchiano, scuotono delle piccole maracas, pregano, lasciano un'offerta. Changó è l'orisha del babalawo che abita qui, sacerdote, indovino ed erborista, perché le piante dell'ewe, il bosco, sono centrali nella santería e hanno mille poteri. Da quando è permesso il lavoro indipendente, ha un suo negozietto con l'insegna di yerbero, sulla porta del quale campeggia un'immagine di Giovanni Paolo II.
La recente visita del Papa a Cuba ha acceso i riflettori sulla Chiesa cubana, che ha recuperato libertà di movimento e vede ora crescere il numero di battezzati, mentre svolge un ruolo importante nella transizione verso il dopo Fidel Castro. Ma il cattolicesimo ha una diffusione limitata nella società cubana, anche lasciando da parte gli effetti di tre decenni di stato ateo e di educazione socialista. La forma di religiosità più capillarmente presente sull'isola è quella dei vari culti afrocubani, primo fra tutti la santería o Regla de Ocha, derivata dal pantheon yoruba della Nigeria mimetizzato, per poter sopravvivere in epoca coloniale, associando a ogni orisha un santo cattolico, o una Vergine locale particolarmente venerata: quella di Regla, presso l'Avana, è Yemayá, madre della vita e del mare; quella del Cobre, presso Santiago, è Ochún, dea dell'amore e del fiume. Le disperse credenze — in cui ad ogni orisha corrispondono come attributi certi ornamenti, numeri, cibi, colori, leggende e capacità terapeutiche — sono state unificate circa cent'anni fa, tra Matanzas e Regla, da Lorenzo Samá e la sacerdotessa Latuán e dalla loro sistemazione ha preso corpo la pratica attuale.
Malvista un tempo come sinonimo di superstizione, la santería è ora un ingrediente immancabile del folclore servito ai turisti, dalle coreografie ai souvenir. Sono sempre rimasto un po' dubbioso sul mondo dei babalawo per stranieri in cerca di suggestioni, anche se alcuni mi sono parsi acuti psicologi dotati di un forte senso teatrale: conversano con il cliente come consulenti spirituali, azzeccano imprevedibili dettagli del suo passato e individuano i suoi crucci, interrogano l'obi, le scorze di cocco divinatorie, o le carte per rispondere ai suoi quesiti, sgozzano un galletto e una colomba alla luce di un cero, recitano formule esotiche e forniscono l'oggettistica con cui il neo-adepto rincaserà protetto da curiosi talismani.
Il rispetto per qualcosa di così fondamentale per tanti cubani e così difficilmente comprensibile per un europeo mi ha sempre frenato da incontri diretti, fino al giorno in cui un'amica pittrice mi ha spinto da Moraima, iyalocha (cioè madrina di fedeli e sacerdotessa) dalle ceratteristiche rare. È una signora dalla pelle bianchissima, con occhi celesti trasparenti e una figura delicata, quasi eterea se non fosse per il richiamo terreno della chioma, riccia e fulva nonostante l'età. Vive in condizioni molto povere, ma ha nello sguardo e nei modi una serenità che impressiona. Mi ha ricevuto con un fascio di fili di perline multicolori al collo e un fiore d'ibisco tra i capelli. In un angolo della sua stanza c'era un altarino stracarico, con vasetti pieni d'acqua e ciottoli o foglie, alcune foto stinte e un grande quadro raffigurante un negro seduto, con un bastone di legno in una mano e una bandiera nell'altra. È il morto con cui Moraima comunica.
Per me Moraima ha fatto parlare il diloggún, una manciata di conchiglie che rovescia su un tavolino e poi conta secondo una tecnica tramandata da generazioni. Le domande le ho fatte tra me, in silenzio. Le risposte che Moraima mi dava erano sibilline, eppure mi nasceva dentro subito la loro interpretazione, tutt'altro che sciocca. Poi mi ha detto che come amuleto andava bene quello che portavo (fabbricato da me, che lei non poteva vedere), ma che avevo addosso un'anima sola e dovevo liberarmene. Si trattava di un'infelice anima del purgatorio senza preghiere di suffragio, costretta da qualcuno che mi voleva male a starmi appiccicata e contrastare i miei buoni rapporti con il gentil sesso. Sono molto sensibile a tale argomento e ho accettato subito il rito purificatorio, durante il quale, mentre un cerchio d'alcol mi bruciava intorno, il fumo del tabacco indigeno ha aiutato la malcapitata anima a tornarsene in pace al purgatorio.
Da allora il mio bilancio sentimentale è in netto recupero, ma il più bel regalo che mi ha fatto Moraima sono state le storie che mi ha raccontato, sventagliandosi come una nobildonna spagnola, nel cortiletto dei banani. Storie di terribili malefici di tempi remoti, quando agli stregoni africani bastava raccogliere un po' di polvere calpestata al mattino dalla loro vittima per provocarne la morte entro sera. Storie di piante capaci di avvelenare e produrre pazzia, ma anche di proteggere dagli spettri, far innamorare o guarire. Storie legate a un orisha, come quella che riguarda Babalú Ayé, cioè San Lazzaro: era un gran libertino e non si perdeva una festa, finché la sua stessa moglie Ochún lo lasciò; il saggio Orula lo avvertì di non giacere con donne il Giovedì Santo, ma lui non fece caso al consiglio e il giorno dopo aveva il corpo coperto da piaghe purulente; la gente lo sfuggiva e lo seguivano soltanto dei cani; morì, ma Ochún ne ebbe pena e con le sue grazie ottenne che il supremo Olofi lo resuscitasse; ora Babalú Ayé sa bene quanto soffrono i malati e da quando è tornato è molto caritatevole.
Rammento questa storia perché ha dei tratti in comune con quella di Moraima stessa, un'esile signora bianca che da decenni interpreta la santería come misericordia. Negli anni '50, prima della Rivoluzione, il marito di Moraima era un noto chirurgo. Lei s'ammalò gravemente e lui la operò, ma le cose non andarono per il verso giusto e lei fu data per spacciata. Il marito non si arrese e continuò contro il parere dei colleghi, riuscendo miracolosamente a salvarla dal coma irreversibile. Moraima tornò dunque dal regno della morte e cominciò il suo cammino religioso votandosi "al soccorso di chi si trova nei guai", come è solita dire, "per meschini che siano questi guai, perché la vita è fatta insieme di cose grandi e di cose piccole".
Tramite Moraima ho conosciuto Ángel, che ora sta guidando il canto con l'arte di un vero emulo di Mercedita Valdés, la voce per eccellenza delle melodie afrocubane, da poco scomparsa. Ángel si è avvicinato alla santería in carcere e, scontata la pena, ha deciso di diventare oriaté, una vera guida capace di condurre gli altri fuori dalle cattive scelte che lui stesso, in gioventù, ha sconsideratamente fatto. Adesso Ángel suda a rivoli mentre cala il sole sull'Avana e io cerco di dondolare con la stessa cadenza dei fedeli che ballano intorno a me, cerco di ripetere le stesse parole in yoruba e mi sento anch'io un po' uno schiavo che si libera. Nel battere incessante dei tamburi penso che la forza della santería non sta nella paure ancestrali cui rimandano certi suoi simboli, ma nella sua capacità di desiderare la felicità provenendo dal dolore, il più nobile percorso dell'anima.
Non so come riescano i cubani a far convivere stralci di cattolicesimo con questi dèi africani elementari e colorati che abitano zuppiere, frutti o pietre come cappelle e il cui aché o potere sta in ogni erba o ruscello della foresta. Ma sono certo che la dimensione di solidarietà che si crea nella santería tra confratelli ha contribuito a rendere più sopportabili questi duri anni di crisi economica. Perché la magia della santería non è in fatture e sortilegi più o meno sanguinolenti, ma nel suo carattere egualitario, quasi senza gerarchie. I sacerdoti sono solo dei fedeli più esperti, dotati di aché, cioè di un carisma particolare, che diventano parenti-consiglieri. Ogni linea di queste famiglie di fede, ogni casa è un piccolo tempio.
Così, se le chiese a Cuba restano poco affollate, in tantissime abitazioni, di ogni razza e condizione, si vede in un angolo accanto alla porta un Elegguá di pietra e cemento con gli occhi di conchiglia, circondato da giocattolini e caramelle: è il dio burlone e infantile come il destino, che apre e chiude le strade. E lì accanto c'è la ciotola con i ferri del fabbro Oggún e l'arco e le frecce del cacciatore Ochosi. E in qualche punto alto della stanza c'è il galletto di metallo di Osun, messaggero di Obbatalá, dio del pensiero e della giustizia. E magari Osain, signore delle piante medicinali, sta appeso sulla soglia dentro una zucca o un guscio di tartaruga. Di Osain si dice che sia un accanito fumatore di sigari e che si diverta ad apparire, tutto verde com'è, a chi fa le ore piccole, chiedendogli da accendere. Bisogna tirar fuori un fiammifero e accontentarlo, anche se vi trema la mano.
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2019 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados